Intervista a Simona Cozzupoli, artista visiva
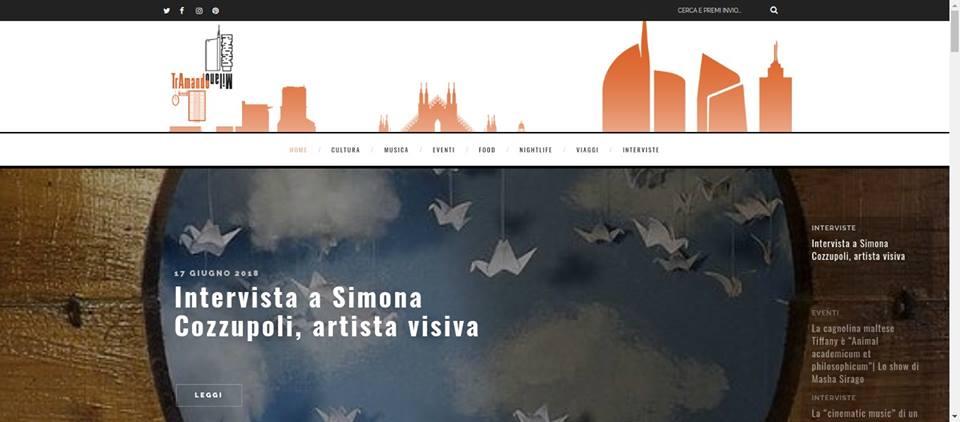
Parli spesso di indole contemplativa, peraltro evidente nella realizzazione dei tuoi lavori. Ci vuoi dire cosa intendi per e cosa ricavi dalla contemplazione?
Quando parlo di “indole contemplativa” mi riferisco alla tendenza a cogliere il lato misterioso e segreto di oggetti, situazioni o luoghi in grado di stimolare visioni interiori. Giorgio de Chirico parlava di “lato metafisico” delle cose. In quest’ottica tutto ha un doppio aspetto: quello corrente, percepito dai più, e quello metafisico, che si offre alla vista di un ristretto numero di individui e, per di più, in rari momenti di chiaroveggenza.
L’idea che anche nella quotidianità più banale ci siano simboli e metafore che rinviano oltre il mondo visibile è il punto di partenza della mia riflessione artistica.
Essenziale per la rivelazione del senso ulteriore delle cose è l’immaginazione, che permette di modificare il mondo esterno secondo la propria interiorità.
Per “contemplazione” intendo il suo significato etimologico: la parola deriva dal latino “templum”, che indicava la porzione circolare di cielo descritta e consacrata dal sacerdote etrusco (l’àugure) facendo roteare in aria un apposito bastone, detto “lituo”, per osservarvi il volo degli uccelli e trarne il responso degli dei tramite gli “auspici” (da “avis”: uccelli e “spicere”: osservare). “Contemplare” significava dunque, in origine, “osservare il volo degli uccelli” e, in senso lato, “sollevare il pensiero e lo sguardo verso l’alto, verso qualcosa che susciti meraviglia, con atto prolungato e intenso”.
Dalla contemplazione ricavo la possibilità di favorire le facoltà poetiche (proprie dei bambini e dei primi uomini), che rimangono solitamente sopite se si rivolge per troppo tempo lo sguardo verso il basso. È così che nascono le mie creazioni: dalle visioni interiori rese possibili dal recupero dell’antico stupore
Hai allestito varie mostre a Milano in location molto particolari, ce ne vuoi parlare?
Tutto è iniziato a marzo dell’anno scorso, quando un pomeriggio, passeggiando sul Naviglio Grande, ho notato una piccola vetrina sulla strada, divisa in scomparti di legno sui quali erano disposti con cura alcuni oggetti ricercati e bizzarri in stile Wunderkammer (“camera delle meraviglie”): era l’ingresso del BackDoor43, il bar più piccolo del mondo, nel quale si entra su prenotazione al massimo in tre persone alla volta.
In quel momento ho subito pensato che il concetto di meraviglia sotteso alle mie opere potesse adattarsi perfettamente ad una location così particolare.
La vetrina, infatti, si è rivelata uno sfondo molto indicato per ospitare i miei micromondi in bacheca, cioè scatole di legno che sembrano riprodurre in piccolo una vetrina, con un effetto di mise en abyme che ho voluto sottolineare esponendo “Alice nella camera delle meraviglie”, dove alle spalle di una bambolina bionda, l’Alice di Carroll, sono appese altre minuscole teche, come in un gioco di specchi. In altre parole, il locale era una meravigliosa bacheca che ho allestito con altre “bacheche” delle meraviglie.
Anche l’interno del locale, un micro cabinet des curiosités con boiserie e soffitto altissimo su cui è riprodotta l’immagine di un antico planisfero, è risultato uno scenario particolarmente adatto per le mie creazioni. La collezione di finte Farfalle con vera nomenclatura scientifica, i pesci di carta degli Acquari, il miscuglio bizzarro di oggetti dei Rebus oggettuali, le “bacheche” con bamboline e i Disegni, sembrano confondersi con gli elementi d’arredo già presenti.
Mi sono divertita a “firmare” l’allestimento del locale mettendo in vetrina una manciata di origami in miniatura, segno distintivo di tante mie “bacheche”, e un cartiglio spiegazzato, a imitazione di quelli dipinti a trompe-l’oeil da Giovanni Bellini, con le iniziali del mio nome: “S. C. ME FECIT MMXVII”.
Qualche mese più tardi, alla fine dell’estate, sono stata invitata ad arredare con le mie opere il Mag Cafè, noto locale sui Navigli in stile bohémien, situato proprio a fianco al BackDoor43, col quale condivide il gusto caldo, raffinato e rétro dell’arredamento. Anche qui le mie opere si sono integrate facilmente fino quasi a mimetizzarsi con l’ambiente, mostrando in particolare alcune coincidenze tematiche con oggetti decorativi preesistenti. In particolare, sono risultati in comune il tema esotico dei pappagalli e quello relativo all’immaginario visivo di Alice nel Paese delle meraviglie.
Quest’inverno ho accettato con piacere l’invito a realizzare una mostra, intitolata La meraviglia, in un terzo cocktail bar sul Naviglio Grande, poco distante dai primi due: il Bond, un locale sobriamente elegante, dall’atmosfera raffinata, arredato in stile minimalista.
A maggio, ho allestito la mostra Le piccole stanze delle meraviglie a Le Biciclette – Ristorante & Art Bar, storico locale milanese in zona Colonne di San Lorenzo, nato in un’ex officina di biciclette e punto di riferimento per la promozione di artisti sin dalla sua apertura nel 1998.
L’11 giugno, infine, si è inaugurata l’esposizione Micromondi. Gioco, meraviglia, sogno e contemplazione presso il caffè letterario Colibrì, uno spazio curato e fiabesco, nella tranquilla via Laghetto a fianco all’Università Statale. Gli ambienti, con pareti spesse, travi e mattoni a vista e arredamento in stile country chic, comprendono la zona bar, una stanza con pianoforte a disposizione di chi voglia suonarlo, una libreria e un cortiletto verdeggiante.
In quest’occasione non ho potuto esporre tre opere, rifiutate perché avevano come soggetto la Madonna: due Rebus oggettuali con soluzione visiva, contenenti entrambi anche la visualizzazione di un’espressione verbale basata sull’etimologia del nome di Maria, e la “bacheca” Madonna con bambino (D’après Giovanni Bellini), che imita, tridimensionalmente, lo stile del famoso pittore rinascimentale che ha codificato la tipologia di questo soggetto iconografico, realizzando numerose varianti sul tema. Non mi è chiaro come queste opere potessero correre il rischio di urtare la sensibilità del pubblico cattolico, chiamato semplicemente a risolvere un rebus o a riconoscere le citazioni dalla scuola veneta tra Quattrocento e Cinquecento…
Hai definito “illuminazione” una sorta di stato animico, di disposizione nel saper vedere la realtà senza schemi mentali precostituiti. Il preconcetto, d’altra parte, è qualcosa in grado di distruggere la limpidezza della visione. Vuoi commentare?
Mi viene subito in mente una frase di Charles Simic, che in un libro su Joseph Cornell, un artista che ha molto influito sulla formazione della mia poetica, scrive: “La chiarezza della visione è un’opera d’arte”.
Il fatto è che la conoscenza è connessa all’atto del vedere. In greco antico il verbo che significa “vedere”, coniugato al passato significa “sapere”, perché l’azione passata di vedere produce il risultato presente di sapere: se “ho visto”, allora “so”, “conosco”.
La conoscenza alla quale giungiamo attraverso la percezione è sempre influenzata e determinata dalla percezione stessa o, meglio, dall’interpretazione che diamo di essa. Lo storico dell’arte Gombrich sintetizza questa interconnessione tra percezione (attraverso la vista in particolare) e conoscenza con una frase molto efficace: “conosciamo ciò che vediamo e vediamo ciò che conosciamo”.
Se la visione del mondo è determinata dal contesto spaziale e temporale in cui viviamo, allora ogni cultura, ogni civiltà e ogni epoca hanno il potere di ridurre le capacità percettive dell’essere umano. Si potrebbe dire che il mondo nel quale viviamo non sia quello reale, bensì una sorta di “prodotto culturale”, frutto di schemi mentali precostituiti che offuscano la limpidezza della visione.
L’illusionismo ottico delle mie “bacheche” intitolate Acquari e Farfalle induce a riflettere proprio sul carattere ingannevole della percezione, che non può darci una conoscenza veritiera e diretta del mondo.
Un antidoto al preconcetto, allora, può essere la ricerca di ciò che è originario, primitivo, preculturale. Anche la sospensione dei nessi di causa-effetto con i quali interpretiamo normalmente la realtà è un valido strumento per ottenere, volontariamente, uno sguardo nuovo anche sull’oggetto più banale. Il dissolvimento della logica porta infatti al recupero dello stato del sogno e dell’infanzia.
L’illuminazione, quindi, non è un’esperienza soprannaturale, ma un riconoscimento della realtà, un “saper vedere” in maniera non condizionata, lucida e, paradossalmente, ad occhi chiusi. “Dovete chiudere gli occhi, altrimenti non vedrete niente” è la frase iniziale che si ascolta in Qualcosa di Alice, un visionario lungometraggio del regista Jan Svankmajer, che ha ispirato alcune mie opere.
Illuminazione è il titolo che ho scelto per un disegno nel quale ho ritratto il viso di una bambola con gli occhi chiusi e il “terzo occhio” aperto, un organo che, nella tradizione induista, è preposto alla visione sovrasensibile, alla quale si giunge varcando la soglia che separa (e unisce) il mondo del visibile ordinario da quello dell’invisibile stra-ordinario, dove è possibile sperimentare stati di “coscienza allargata”.
Nel Tao Te Ching si legge che “la conoscenza di se stessi è illuminazione”. Conoscendo se stessi, infatti, si conosce il mondo intero: questo è anche l’insegnamento dell’iscrizione “conosci te stesso” nel tempio di Apollo a Delfi.
Potrei quindi definire “illuminazione” il momento in cui si ha la chiara visione delle interconnessioni esistenti tra microcosmo e macrocosmo.
Sei laureata in Lettere con indirizzo in Storia e Critica delle Arti presso l’Università degli Studi di Milano. Che ruolo ha giocato la tua formazione? Credi avresti intrapreso comunque la carriera di artista o che riusciresti ad operare a prescindere da essa?
Sono sempre stata attratta dall’arte. Finito il liceo avevo pensato di iscrivermi all’Accademia di Belle Arti di Brera, ma poi ho scelto Lettere: credo di aver intuito, in quel momento, che avrei avuto bisogno di un periodo di “incubazione” dedicato allo studio “teorico” dell’arte prima di poter passare alla fase “pratica”. Oggi vedo il mio percorso di studi come qualcosa di complementare rispetto alla mia attuale attività artistica. L’interesse per le etimologie delle parole, per esempio, nato durante l’università, si è rivelato in seguito uno stimolo fondamentale per la realizzazione di alcune opere. Lo studio della storia dell’arte, poi, rappresenta per me una fonte di ispirazione, come rivelano le opere stesse: i pappagalli di carta che ricordano quelli nelle scatole di Joseph Cornell, i piani inclinati delle Nature morte contemplative derivati da de Chirico o le bamboline nude che sembrano riprodurre i tableau vivant di Vanessa Beecroft.
Non è facile ipotizzare cosa farei oggi se in passato avessi intrapreso un altro percorso di studi, posso solo dire che i due diversi approcci con i quali mi sono avvicinata all’arte, quello teorico e quello pratico, sono intimamente connessi.
Quali sono i punti di riferimento della tua peculiare estetica?
Prima di tutto l’insegnamento che ho tratto dalla pittura metafisica di Giorgio de Chirico, un artista che ha saputo creare atmosfere enigmatiche e oniriche, pur dipingendo con un linguaggio figurativo tradizionale. Proprio nel contrasto tra il realismo esecutivo e l’irrazionalità delle composizioni, create con oggetti estranei tra loro, risiede il valore della sua pittura. È da questa concezione dechirichiana, e poi surrealista, fondata sulla decontestualizzazione degli oggetti e sul loro accostamento spiazzante, che nasce l’ispirazione per i miei Rebus oggettuali.
Del surrealista Magritte, un pittore rimasto folgorato da de Chirico, mi affascina la riflessione filosofica sul rapporto complesso esistente tra immagini e parole. Dal punto di vista visivo mi attraggono i suoi cieli azzurri attraversati da fiabesche nuvole bianche, che ho “tradotto” tridimensionalmente utilizzando imbottitura per cuscini su sfondo azzurro, in varie “bacheche”.
Un altro riferimento, non a caso anch’egli grande ammiratore di de Chirico, è l’artista americano Joseph Cornell, che ha percorso a piedi la città di New York, alla ricerca degli oggetti da collocare nelle sue scatole, come si attraversa la baudelairiana “foresta di simboli”. La sua premessa era che, da qualche parte in città, dovessero trovarsi, sparsi chissà dove, gli oggetti da accostare nelle sue opere e che avrebbe dovuto assolutamente trovarli. Questa idea di base che l’arte non si crea, ma si trova e che ciò che conta è l’interpretazione che diamo alla percezione più che la percezione stessa, mi trova completamente d’accordo e rappresenta un punto di partenza delle mie riflessioni. Quando vago per mercatini dell’usato e dell’antiquariato per le mie creazioni mi viene spesso in mente il peregrinare di Cornell tra i robivecchi della New York di inizio Novecento: anche per me si tratta di un’attività sacra, di una sorta di pratica divinatoria.
Di Italo Calvino mi interessa l’idea di letteratura come gioco combinatorio presente nel romanzo fantastico Il castello dei destini incrociati. Qui la storia nasce e si evolve in base alla combinazione casuale di un mazzo di tarocchi, le cui figure vengono disposte in modo da creare una storia dotata di senso. Mi sono ispirata proprio a questo meccanismo compositivo nella creazione delle “bacheche” con le figure delle carte da gioco.
Un altro esponente della letteratura fantastica che ha esplorato le possibilità dell’arte combinatoria è Jorge Luis Borges: quello che amo di più nei suoi racconti è la comicità che scaturisce dalla coerenza nell’irrazionale.
Tra i punti di riferimento della mia estetica c’è poi il pensiero di Alejandro Jodorowsky, un uomo che ha compreso, come Jung, che la pratica divinatoria può essere anche un metodo di esplorazione dell’inconscio e che attraverso i sogni lucidi, cioè quelli in cui siamo consapevoli di sognare, possiamo influenzare la realtà così come questa influenza i nostri sogni.
Per quanto riguarda la dimensione onirica, che rappresenta una tematica costante nelle mie opere, ho trovato ispirazione anche nella poetica di Jan Svankmajer. Questo regista ceco, utilizzando la tecnica dello stop motion, dà vita a storie surreali che nascono da oggetti quotidiani utilizzati in maniera del tutto inaspettata. Guardando i suoi film si sperimentano modalità di pensiero simboliche, metaforiche e analogiche tipiche del sogno.
Nei saggi di René Guénon e di Ananda Coomaraswamy ho scoperto il significato originario di numerosi simboli comuni a più civiltà e la loro trasformazione nel corso del tempo, spiegata attraverso le due categorie contrapposte di “tradizionale” e “moderno” o, in altre parole, di “sacro” e “profano”.
Molte delle tue opere sono “bacheche”, microcosmi in cui confluiscono e interagiscono varie discipline e concezioni. Ci racconti qualcosa in merito?
Le “bacheche”, prevalentemente di piccole e piccolissime dimensioni, sono scatole di legno, chiuse anteriormente da un vetro, che io intendo come piccole stanze o teatri con la “quarta parete” trasparente. La scatola ha per me il significato di uno scrigno o di un reliquiario che custodisce ciò che è prezioso e sacro: l’infanzia, il gioco, la meraviglia, l’immaginazione e il sogno.
Ho realizzato diverse tipologie di “bacheche”. Tra queste, alcune hanno come protagoniste delle bamboline che, nella loro immobilità, vogliono evocare le atmosfere enigmatiche e sospese della pittura metafisica e dei manichini dechirichiani.
Altre scatole presentano una o più aperture circolari che inquadrano porzioni di cielo attraversate da nuvole e uccellini origami in miniatura: le ho intitolate “Templum” e “Templa”. Osservandole, lo spettatore può raggiungere una visione lucida del presente, traendo i suoi “auspici” interiori.
I Rebus oggettuali hanno un doppio piano di lettura: si può decidere di risolverli traducendo le immagini in parole, oppure di guardarli come mere composizioni bizzarre di oggetti intorno alle quali costruire delle storie immaginarie.
Un’altra tipologia di “bacheche” è quella con le figure delle carte da gioco, ritagliate e ricontestualizzate in giardini e teatri in miniatura. In esse chiunque può provare a riconoscere una trama, facendo così emergere qualcosa dal proprio inconscio.
Gli Acquari e le Farfalle, realizzati ritagliando le immagini da libri scientifici sulla fauna marina e sui lepidotteri, rinviano all’universo caleidoscopico delle Wunderkammer. Hanno in comune l’illusionismo ottico: per questo li definisco “trompe-l’oeil oggettuali”.
La tipologia della Natura morta contemplativa consiste in composizioni monocrome di colore azzurro. Queste opere sono create con oggetti di legno disposti su un piano inclinato sospeso tra le nuvole, inquadrati da una o più aperture circolari o ellittiche che alludono al “templum”. L’azzurro favorisce la meditazione, innalza la composizione a un livello di astrazione, collocandola in una dimensione immateriale.
Naturalmente non tutte le “bacheche” rientrano in una di queste tipologie. Per fare solo un esempio, ho realizzato una mnemotecnica, ossia una tecnica che, sfruttando la memoria visiva, facilita la naturale capacità umana di memorizzazione. Sopra la testa di una bambola, qui usata come simbolo della memoria, ho collocato un palazzo-cassettiera, con cassetti al posto delle finestre e ante al posto delle porte, per visualizzare l’antica “tecnica del palazzo della memoria”. Nei cassetti (della memoria) ho disposto gli oggetti-concetti da ricordare.
In generale, tutte le “bacheche” sono “microcosmi”, come dici tu, nei quali condenso alcuni concetti propri delle discipline che indagano la tradizione: la dimensione dell’infanzia, l’origine, il gioco, il rapporto tra immagini e parole, la meraviglia, il sacro, la dimensione onirica, la “sincronicità” junghiana, la divinazione e tutte le modalità di pensiero proprie dell’uomo delle origini e del bambino piccolo.
A tuo avviso, qual è la funzione dell’arte visiva nella contemporaneità? Una mera narrazione per immagini o qualcosa che dovrebbe indurre a fermarsi e riflettere?
Sicuramente l’arte ha la funzione di indurre a fermarsi e riflettere. Per quanto utopico possa sembrare, ritengo che, soprattutto oggi che la crisi della civiltà moderna è avvertita da un numero crescente di persone, l’arte debba porsi come scopo finale la trasformazione della realtà, attraverso lo stimolo alla riflessione offerto dalle opere. “L’importante è creare oggetti, da collocare fuori di noi, bene staccati da noi”, scriveva Massimo Bontempelli, teorico del Realismo Magico, “e con essi modificare il mondo”. È un’affermazione che mi trova totalmente d’accordo.
L’opera d’arte è sempre un “semioforo”, cioè un portatore di significato che rappresenta l’invisibile, e va dunque interpretata. Esponendosi allo sguardo, mostra il suo potere semiotico e svela il suo significato: per sua stessa natura induce a riflettere.
Personalmente, cerco di coinvolgere l’osservatore delle mie opere invitandolo a fermarsi a guardare particolari minuti, a risolvere rebus, a consultare una mnemotecnica o a riconoscere in un’immagine la visualizzazione di un modo di dire, cullandolo tra i due piani di realtà delle immagini e delle parole, dei quali mostro lo scarto e, talvolta, la coincidenza. In tutti i casi il mio intento è quello di “stupirlo”, non nell’accezione sensazionalistica in cui è a volte inteso oggi il verbo, ma nel suo senso originario, connesso all’idea di fermarsi, come tappa necessaria per poi accedere a un diverso livello di conoscenza (“stupirsi” deriva dal verso “stare” nel senso di “arrestarsi”).
Quando ci stupiamo davanti a un’immagine, per un attimo la nostra usuale capacità di comprensione si arresta, ma in un secondo momento quella sensazione, che si può definire di curiosità mista a timore, diventa uno stimolo a conoscere. Sapersi stupire davanti alla realtà, anche quotidiana e banale, e mantenere la condizione di sorpresa e di meraviglia, è il senso dello stupore come principio della filosofia, cioè della tendenza a riflettere sulla realtà, secondo Aristotele e Platone.
Anche in Oriente c’è la stessa idea: il koan è un’affermazione paradossale che sfida l’intelletto, mette in crisi le nostre consuete modalità di interpretazione/percezione della realtà e ci induce a fermarci, per poi aprirci a un tipo di conoscenza che è oltre la logica.
La funzione dell’arte visiva nella contemporaneità dovrebbe essere proprio questa: di indurre a fermarsi e riflettere: stupirsi e meravigliarsi, per poi conoscere.
Parlaci della dimensione ludica di cui le tue opere sono contaminate. Grazie mille!
Bamboline, barbie, carte da gioco, pezzi degli scacchi, origami in miniatura e giocattoli, sono alcuni degli elementi connessi al gioco presenti nelle mie opere.
Il gioco è strettamente legato all’infanzia ed è anche il fondamento di ogni società, oltre che caratteristica del mondo animale. Costituisce pertanto un fattore preculturale che rientra nella sfera spirituale dell’essere umano, secondo la nota tesi di Johan Huizinga espressa in Homo Ludens.
In base alla corrispondenza olografica tra microcosmo e macrocosmo, all’infanzia del singolo uomo corrisponde l’infanzia dell’intera umanità. Il bambino e l’uomo preistorico della vichiana “età degli oracoli” sono accomunati dalla naturale predisposizione alla poesia e alla chiaroveggenza, cioè a una visione chiara e diretta del mondo nella quale niente appare isolato dal contesto, ma tutto è unito in una complessa rete di corrispondenze. Il bambino piccolo, come il primo uomo, non parla: non fa ragionamenti sulla realtà, ma la vive direttamente.
Alcune “bacheche” sono vere e proprie “stanze dei giochi” abitate da bamboline che, piegando e tagliando un foglio bianco, danno vita a figure tridimensionali inaspettate e meravigliose, che rappresentano collegamenti a mondi immaginari.
Queste scatole-stanze sono micromondi tanto piccoli sul piano fisico, quanto vasti su quello interiore: sono spazi che evocano una dimensione originaria (l’infanzia e la preistoria), nella quale la meraviglia e l’immaginazione sono strumenti essenziali di percezione, focalizzazione e conoscenza della realtà.
Una spiccata componente ludica è presente in tutti i Rebus oggettuali, che coinvolgono lo spettatore in un gioco ermeneutico, analogamente a quanto avviene nella consultazione della mnemotecnica che ho dedicato alla mitica figura di Giano bifronte.
In una Natura morta contemplativa ho inserito un giocattolo il cui funzionamento appare misterioso: è un invito rivolto allo spettatore a “trovare” le regole del gioco semplicemente “inventandole”. Le due azioni sono infatti equivalenti, come rivela l’etimologia di “inventare”, che deriva dal latino “invenire”, cioè “trovare”. La ricerca delle regole del gioco diventa così, a sua volta, un gioco.
Nella serie di “bacheche” realizzate con le figure delle carte, ambientate sul palcoscenico di un teatro o in un giardino fiabesco, Re, Regine, Donne e Cavalieri diventano gli archetipi protagonisti di storie infantili e universali che possono nascere spontaneamente nello spettatore, chiamato a “trovarle-inventarle” partendo dall’osservazione dei loro accostamenti.
Grazie a te!
Hai bisogno di informazioni?
Vuoi chiedere maggiori informazioni? Lasciami un messaggio, risponderò al più presto